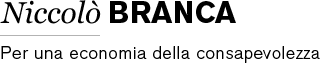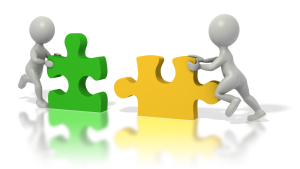L’inizio di ogni anno spesso sollecita riflessioni sulla situazione che stiamo vivendo e sulle mete che ci poniamo come obiettivo.
Anch’io, in queste ultime settimane, ho dedicato alcuni pensieri alle circostanze che definiscono il momento che il nostro paese sta attraversando. Oggi vorrei condividere con voi le mie considerazioni.
Per gran parte del XX secolo la crescita economica e il maggiore accesso all’istruzione superiore hanno fatto sì che in Italia la mobilità fosse generalmente ascendente. La frenata è cominciata negli ultimi decenni, con il rallentamento dell’economia.
Oggi le persone che hanno un’età tra i 25 e i 40 anni rappresentano la prima delle generazioni nate nel Novecento impossibilitata a migliorare la propria posizione sociale rispetto a quella dei genitori.
I dati più aggiornati ci confermano che ormai ci troviamo in una condizione di mobilità discendente.
Credo esista ovunque una correlazione tra background famigliare e livello di istruzione. Ma è indubbio che i nostri laureati faticano più dei coetanei di altri paesi a inserirsi nel mercato del lavoro e beneficiano meno della mobilità sociale offerta da un più alto titolo di studio.
Il dopo-laurea è infatti il punto in cui la forbice sociale si allarga a dismisura, discriminando in modo netto sulla possibilità o meno della famiglia d’origine di mantenere i giovani durante lunghi praticantati, stage poco pagati o scuole di specializzazione. La classe sociale di origine, quindi, influenza inesorabilmente la condizione occupazionale dei giovani.
Mi preoccupa il rischio di porre le basi per un futuro fatto di contesti di lavoro socialmente sempre più omogenei, che di sicuro si riveleranno problematici. Non solo da un punto di vista etico, ma anche perché è ben documentato che la diffusione dell’equità e della meritocrazia porta benefici concreti a livello sociale ed economico.
Per questo motivo, ad esempio, in UK dal 2011 esiste una commissione governativa, la Social Mobility Commission, che monitorando sistematicamente la mobilità sociale, propone riforme e politiche mirate.
Le iniziative cominciano nelle scuole d’infanzia e seguono gli studenti lungo tutto il percorso scolastico, fino agli stage lavorativi.
Inoltre, per permettere l’accesso alle professioni anche ai giovani che non hanno una famiglia abbiente alle spalle, i datori di lavoro sono incentivati a offrire stage retribuiti al di sopra del salario minimo.
Mi sembra, questo, un buon esempio di ciò che si potrebbe fare per cercare di modificare radicalmente alcuni comportamenti sedimentati nelle nostre società. Naturalmente ci vorrà tempo prima che gli obiettivi delle riforme siano raggiunti. Sarebbe perciò essenziale, anche nel nostro paese, cominciare ad attivarsi seriamente intorno a questa problematica e che tutti – università, aziende, istituzioni pubbliche – si impegnino a mettere a disposizione il proprio contributo.
Lo scorso agosto l’Eurostat, l’ufficio di statistica europea, ci ha fatto sapere che l’Italia detiene il record negativo dei Neet (Not in Education, Employment or Training): i giovani tra i 15 e i 29 anni che non vanno a scuola o all’università, che non lavorano, né seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale.
Un esercito sempre più disincantato e disilluso che vaga senza meta, senza aver chiaro il proprio ruolo nella società e nel mercato del lavoro, senza un progetto su cui riversare il proprio interesse e i propri sogni, con il timore di essere marginalizzato e di dover rinunciare definitivamente a un futuro di piena cittadinanza.
Un esercito che sembra scivolare verso i confini del mercato del lavoro e rischia di trasformarsi in disoccupazione strutturale. In seguito nemmeno i contratti più flessibili riuscirebbero a inserirla nel mondo del lavoro, con conseguenze a catena anche dal punto di vista pensionistico.
Gli esperti ci dicono che il fenomeno è molto più accentuato nei paesi del sud e dell’est europeo. Da cosa dipende questa variabilità?
Credo la si possa interpretare attraverso le caratteristiche del regime di welfare e del regime di transizione all’età adulta nei diversi paesi Europei.
La condizione di Neet, infatti, è sì conseguenza della crisi economica e della modesta mobilità sociale, ma sul fenomeno influisce anche la poca autonomia giovanile. Perciò sono i paesi europei dove i giovani restano più a lungo a casa con i genitori, a registrare un’alta presenza di Neet.
Quello dei giovani è un tema che mi sta molto a cuore, perché le nuove generazioni sono la componente più preziosa per realizzare il benessere di un paese.
Per questo credo davvero sia tempo di tornare a occuparsi dei ragazzi, orientarli al sapere professionalizzante, favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro, creare dei percorsi virtuosi che favoriscano l’alternanza scuola-lavoro, dare vita a procedure veramente meritocratiche di selezione professionale. Senza trascurare un’organica serie di politiche economiche, lavoristiche, educative, edilizie, di welfare, per accrescere le possibilità dei giovani italiani di emanciparsi dalla dipendenza materiale dalla famiglia d’origine che, paragonata ai loro coetanei di altri paesi europei, appare eccessivamente lunga.
Sono convinto che i benefici creati da un ampliamento dello spazio dedicato ai giovani nel mercato del lavoro sarebbero innumerevoli, e a vantaggio di tutti: dall’impatto sulla produttività a quello sull’innovazione, dalla modernizzazione di tempi e luoghi di lavoro alla coesione sociale.
Tuttavia, questa sorta di letargo esistenziale, non riguarda solo i giovani Neet, ma può essere esteso alla più ampia composizione sociale.
Nel nostro paese, purtroppo, continua a vincere il soggettivismo, l’egoismo, l’interesse individuale. Non maturano invece i valori collettivi, l’unità degli interessi. Anche per questo crescono le diseguaglianze, con la conseguente caduta della coesione sociale.
È un’Italia vivace e dinamica quella che posso vedere da Milano, una città che combina tecnologia, industria, design, cultura e comunicazione.
Ma basta cambiare punto di osservazione e dalle cronache emerge il ritratto di un paese gravemente diseguale. Il Nord in crescita, per capacità produttiva e redditi. Il Sud invece povero e marginale, con processi industriali sempre più rarefatti e aggrovigliato in una spesa pubblica assistenziale, clientelare, carente di risorse, di strumenti per l’integrazione, di servizi sociali, per la formazione e il lavoro.
È lo specchio di un contesto culturale che, alimentando passività e disagi, favorisce condizioni di marginalità e povertà. E i numeri delle statistiche non fanno che aggiungere drammatica attualità al problema: il PIL pro capite nel Mezzogiorno è quasi metà di quello del Nord.
Un divario antico eppure crescente, con una forbice di opportunità, speranze, prospettive di lavoro che si aggrava, soprattutto per le nuove generazioni.
Impossibile non percepire con sempre più chiara consapevolezza che tale divario è intollerabile e che, oltre a dividere il Paese, continuerà anche sul lungo periodo a deprimerne la crescita.
Non dimentichiamo, infatti, che siamo tutti legati gli uni agli altri in una relazione di interdipendenza e, senza rimettere il Mezzogiorno sul treno dello sviluppo, nessuno starà bene davvero e non ci sarà sviluppo europeo per nessuno, in Italia.
Niccolò