La settimana scorsa ho incontrato Jacopo, un amico che non vedevo da molti anni.
Dopo pochi minuti i primi discorsi un po’ impacciati hanno lasciato il posto a un’autentica comunicazione, come spesso accade con le persone con cui abbiamo costruito rapporti intensi e veri.
Così, in breve tempo, recuperando decenni vissuti in paesi diversi, ci siamo aggiornati sui fatti salienti delle nostre rispettive esistenze, con brevi accenni alle gioie e ai successi, ma senza certo trascurare le amarezze, le sofferenze, i lutti, proprio come fanno gli amici più cari.
“E sai perché non ci siamo mai fatti abbattere?” mi ha chiesto all’improvviso Jacopo con un sorriso. “Ti ricordi il rafting? Chi si impegna e ama le sfide, è più resiliente!”
In effetti, da ragazzi, io e Jacopo abbiamo condiviso alcune significative esperienze, prima fra tutte il white water rafting, che entrambi abbiamo praticato, con identico entusiasmo, fino al sesto grado.
Ma ho sempre pensato a quel periodo, come a uno dei più spensierati della nostra vita. È stato proprio Jacopo, con quella sua osservazione, a offrirmene invece una prospettiva differente e decisamente più complessa.
A quel tempo la nostra passione per il rafting, unita alla fascinazione per i corsi d’acqua ancora inesplorati, ci aveva condotti in diverse parti del mondo, coinvolgendoci in discese fluviali di sempre maggiore difficoltà.
Sapevamo che quelle rughe della terra, scavate da acque di cui la geologia sembrava considerare solo la capacità erosiva, erano in molti casi luoghi sacri ad altre culture. A noi apparivano soprattutto come un tramite tra il nostro mondo e la meraviglia di dimensioni inesplorate o quasi inaccessibili, punteggiate da altre abitudini, altri stili di vita, altre culture.
In Zambia avevamo incontrato lo Zambesi nel punto in cui manifesta tutta la sua potenza trasformandosi nella più maestosa caduta d’acqua del pianeta, le Victoria Falls, descritte da David Livingstone come il più straordinario spettacolo che avesse mai visto.
I Kokolo, che invece a quello spettacolo sono avvezzi, da sempre le chiamano più prosaicamente Mosi-oa-Tunya, il “fumo che rimbomba”, riferendosi solo al suono fragoroso e alla coltre di vapore che producono. Tuttavia, proprio tra quei giganteschi spruzzi, in cui il gioco della rifrazione solare ricrea non di rado l’incanto dell’arcobaleno, il popolo dei Tonga continua a scorgere il luogo in cui dimora Dio.
Seguendo il corso dello Zambesi, sfidando l’insidia dei coccodrilli e di molte altre specie di rettili, avevamo poi attraversato l’intrico vegetativo della foresta pluviale fino al lago Kariba, in Zimbabwe.
In quelle acque tranquille avevamo potuto finalmente riposarci, condividendo con alcuni pescatori il loro cibo e dedicandoci all’osservazione sempre elettrizzante di grandi erbivori come ippopotami, elefanti, bisonti e rinoceronti neri, ora a rischio di estinzione.
Nella mia mente, il ricordo di quell’esperienza è associata ancora oggi al profumo intenso delle spezie africane e al suono del gracidio di migliaia di rane.
L’esplorazione del fiume Congo, quando ancora si chiamava Zaire, ci aveva invece regalato l’indicibile emozione dell’incontro, nella foresta dell’Ituri, con uno sparuto gruppo di pigmei, o batwa come li chiamano i Bantu, piccoli uomini.
Infine, sulle orme di Hermann Hesse, eravamo approdati nell’isola di Sumatra, in Indonesia. Nella foresta pluviale avevamo affrontato le rapide mozzafiato dell’Alas River, sovrastati dal volo suggestivo ma un po’ inquietante degli enormi buceri rinoceronte.
Nel suo percorso, il fiume non cessava di rivelare forme vegetative dalle dimensioni e dai colori sorprendenti, mentre il richiamo costante dello siamang sembrava volerci ricordare, momento dopo momento, il sacro privilegio di essere nel cuore della biodiversità.
Ammetto, ora, che il mio ricordo si è per lo più focalizzato sul fascino avventuroso di quell’esperienza. Quasi mai sulla fatica estenuante, sulle ferite provocate dalle sanguisughe, sul rischio rappresentato dai serpenti velenosi, sui gravi incidenti effettivamente accorsi, sulle notti trascorse in tende montate in piccoli spiazzi fangosi, immerse in rumori sconosciuti e in un’umidità ardente.
Il confronto con queste avversità e con la forza prorompente delle acque impetuose mi è sempre apparso, anche a quel tempo, come una sfida stimolante e irrinunciabile. Un prezzo più che equo da pagare, per ricevere in premio l’accesso a mondi altrimenti inavvicinabili, che valicavamo di volta in volta con rispetto e gratitudine.
Il processo selettivo della memoria mi ha fatto dimenticare, nel corso del tempo, anche altri aspetti piuttosto faticosi: i lunghi periodi di disciplina rigorosissima che dovevano tassativamente precedere ognuna di queste spedizioni.
Poiché non ci sono ospedali nella giungla, era infatti necessario affrontare le asprezze e le difficoltà di ogni impresa con un fisico forte e uno stato di salute impeccabile. Questo richiedeva mesi di inflessibili allenamenti quotidiani uniti, naturalmente, a una dieta sana e priva di tutte le trasgressioni che i nostri vent’anni ci sollecitavano di continuo, come Jacopo mi ha puntualmente ricordato.
Inoltre, per organizzare una discesa della durata di un paio di settimane si doveva lavorare all’organizzazione anche per un anno intero.
Era essenziale trovare degli sponsor che sostenessero economicamente le nostre spedizioni. Fondamentale studiare accuratamente la geografia e procurarsi mappe affidabili e aggiornate dei percorsi da seguire. Indispensabile la ricerca delle attrezzature e dei materiali più idonei ad affrontare ogni peculiare situazione.
C’era infine la questione dei visti e dei permessi territoriali. Ricordo, ora, che a Medan, nel nord di Sumatra, proprio dove il fiume Alas scorre, abbiamo dovuto fare una sosta piena di complicazioni, per la necessità di consegnare al governatore locale un documento a nostra firma, che lo liberasse da ogni responsabilità in caso di incidenti.
Ma nulla è mai servito a scoraggiarci, a farci desistere. Anzi, più le difficoltà si facevano evidenti, più ci sentivamo stimolati a metterci in gioco, a non farci abbattere.
Questo viaggio nella memoria ha dato, in effetti, un significato vero e profondo all’iniziale esclamazione di Jacopo “Chi si impegna e ama le sfide, è più resiliente!”
Ma la resilienza, la capacità di fronteggiare le avversità e dare nuovo slancio alla propria
esistenza, non è una caratteristica che è presente o assente in un individuo.
Può anche essere sollecitata, ci assicura la psicologia, attraverso comportamenti, pensieri
e azioni.
Secondo Susanna Kobasa, una psicologa dell’università di Chicago, le persone che meglio riescono a fronteggiare le contrarietà della vita, quelle più resilienti appunto, mostrano contemporaneamente tre tratti di personalità: l’impegno, il controllo e il gusto per le sfide. Esaminiamoli insieme.
Impegno La persona con questo tratto si dà da fare, è attiva, non si spaventa di fronte alla fatica, non abbandona facilmente il campo. È attenta e vigile, valuta le difficoltà realisticamente. Si pone degli obiettivi in cui crede e per cui è disposta a lottare.
Controllo La persona con questo tratto non è mai in balia degli eventi. Per dominare le diverse situazioni della vita è pronta a modificare anche radicalmente la strategia da adottare: talvolta interviene con grande tempestività, in altre circostanze indietreggia e prende tempo.
Gusto per le sfide La persona con questo tratto è aperta e flessibile. Sa accettare i cambiamenti e li vive più come opportunità di crescita che come difficoltà da evitare a tutti i costi. Vede gli aspetti positivi delle trasformazioni e minimizza quelli negativi. Per questo considera le sfide stimolanti, non minacciose.
Impegno, controllo e gusto per le sfide sono tratti di personalità di cui si può avere consapevolezza e, proprio in questo modo, possono essere coltivati e incoraggiati.
Ora anch’io, come Jacopo, sono convinto che il white water rafting ci abbia insegnato a guardare le cose con reale distacco e ci abbia permesso, per tutti quegli anni, di coltivare il gusto per le sfide ardue e difficili. Gusto che in seguito abbiamo semplicemente traslato ad altri settori.
È certo che oggi continuo a definire “sfide”, quelle che ad altri possono sembrare solo ostiche problematicità. Trovo sempre galvanizzante doverle affrontare perché so che, anche quando si rivelano estenuanti, hanno in ogni caso un effetto corroborante: non mi sono arreso, ho combattuto, ho fatto emergere da me stesso delle qualità che non sospettavo nemmeno di avere.
E da tutto questo, comunque sia finita, ho acquisito più forza interiore.
Niccolò
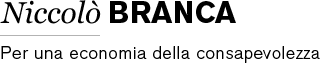




Delle tre caratteristiche evidenziate, penso che il Controllo sia la più critica; nella misura in cui spesso si insegue il “controllo totale” (utopia) degli agenti esterni, quando invece sarebbe meno dispendioso e più efficace ricercare il “Controllo del proprio agire”, la consapevolezza.
Questo switch di modello comportamentale, probabilmente, è legato a doppio filo a temi afferenti l’autostima.
Grazie per gli spunti,
G
Sì, caro Giorgio, il controllo è legato all’io fenomenico e, in quanto tale, è sempre una forzatura.
Non è qualcosa di totalmente negativo: in fondo, prima di abbandonarsi alle proprie energie distruttive va bene anche quel tipo di controllo. Ma ciò a cui dobbiamo davvero mirare è lo sviluppo della consapevolezza.
Quella consapevolezza presimbolica che ci porta a essere in intimità con tutto e tutti, quindi ci fa agire sia per il nostro bene che per il bene degli altri.
Un caro saluto
Niccolò